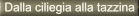
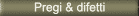
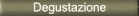
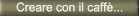
Pregi e difettiNell'ottobre 1970, a Venezia, si è tenuto il Primo Simposio Biofarmacologico sul caffè. L'anno dopo, nell'ottobre 1971 a Firenze, si è ripetuto il Secondo Convegno, e nel 1972 a Vietri sul mare un terzo convegno ha integrato e completato l'esposizione delle proprietà delle sostanze attive contenute nel caffè, sancendo chiaramente gli effetti positivi e sfatando i pregiudizi negativi diffusi in passato. Durante questi convegni, esperti nel campo della Dietologia, della Nutrizione, della Fisiologia Umana hanno precisato l'attività terapeutica del caffè, bevanda che in una società come la nostra aiuta a sconfiggere lo stress fisico e mentale, caratteristico della nostra epoca. Dal punto di vista nutritivo il caffè non è un alimento indispensabile per il nostro organismo. Tuttavia, alcune sostanze in esso contenute provocano effetti benefici sugli organi. Naturalmente, come per ogni alimento, è necessario non consumarne una quantità smoderata, se non si vogliono ottenere inconvenienti dovuti all’abuso. L'abitudine a consumarlo quotidianamente non comporta assuefazione anche dopo lunghi periodi. Qui di seguito elenchiamo alcuni degli effetti più frequenti da esso prodotti sul nostro organismo. Il caffè è una sostanza cosiddetta "nervina”, che agisce sui centri nervosi, provocando un senso di benessere generale, spronando ad essere maggiormente vigili ed attivi sul lavoro, non solo fisico, ma anche e soprattutto in quello che richiede maggiore prontezza di riflessi. Tale stimolazione proviene dalla "caffeina", in combinazione con l’acido caffettaninnico (miscela di vari acidi tra cui l'acido clorogenico e l'acido caffeico). La caffeinaLa caffeina, alcaloide che il Runge scoprì nel 1820, si trova oltre che nel seme anche nelle foglie della pianta di caffè, tè, cacao, cola, matè. Ecco perché in alcuni paesi (isola di Sumatra, ad esempio), si fa uso di decotti del fogliame torrefatto. Una tazzina di caffè contiene circa 5 cg. di caffeina e la sua azione eccitante, che si protrae per una a due ore dopo averla bevuta, agendo sul sistema nervoso cerebro-spinale, provoca un risveglio delle facoltà mentali, allontana la sonnolenza, la noia, la stanchezza, anche quella psichica, gli stati depressivi, potenzia le capacità della memoria,dell'apprendimento, dell'intuizione e della concentrazione, facilita la percezione degli stimoli sensoriali, attenua le cefalee e le emicranie in genere. Gli effetti positivi della caffeina sull'attività dei centri nervosi superiori è stata sperimentata con la tecnica dei riflessi condizionati: somministrata in dosi terapeutiche si è osservato che aumenta la rapidità dei riflessi condizionati, mentre si riduce il loro periodo di latenza. La sua azione
benefica arriva anche al cuore, perciò nella farmacoterapia essa
è stata usata anche come cardiotonico. Inoltre, la caffeina potenzia
il tono arterioso, senza alterare la pressione, migliorando anche la circolazione
delle coronarie. Va tenuto presente che le azioni sul cuore sono del tutto
secondarie, e non sono rilevabili nelle dosi usuali di 2 - 3 tazzine.
Ciò vale soprattutto per quelle che possono essere considerate
le azioni negative, ad esempio la tachicardia. La comunità scientifica concorda sulla quantità di caffeina che può essere introdotta in un giorno, indicando 300 mg di caffeina per l'individuo adulto, ovvero circa 4-5 mg di caffeina per kg di peso corporeo al giorno:
Per avere un'idea di cosa significhi in termini di dosaggio, ecco i quantitativi di caffeina contenuti in alcune delle bevande/alimenti più comuni:
Altro punto da chiarire è il ruolo benefico, nullo o dannoso di un moderato consumo di caffè. In questo caso, probabilmente per la limitata conoscenza sul contenuto di caffeina, 1/3 dei medici ritiene dannoso un moderato consumo di caffè (3-4 tazzine). Al contrario, la Comunità Scientifica ha più volte dichiarato che tale dose non inficia la buona salute, ma può essere protettiva su molti organi e apparati (come nel caso del fegato). E ancora, nonostante le numerose sostanze benefiche contenute nel caffè, i medici evidenziano solo il contenuto in caffeina. Pochi sanno dei contenuti - a buoni livelli - in potassio e niacina. Infine, fra le patologie per le quali gli intervistati vedono negativo un consumo di caffè, citano quelle relative al sistema nervoso, nonostante la letteratura scientifica abbia, di recente, riportato evidenze positive non solo relativamente all'aumento di performance mentali nei soggetti anziani, ma anche nella prevenzione del Parkinson e del Morbo di Alzheimer. Il decaffeinato La decaffeinizzazione del caffè è un uso che risale alla prima parte del ventesimo secolo, intorno al 1905, per opera di Ludwig Roselius in Germania. Erroneamente questa metodica viene spesso vissuta come un metodo che priva il caffè del suo aroma: Non è vero! Il gusto del caffè dipende dalla concentrazione delle sostanze aromatiche che si sviluppano durante il processo di tostatura, mentre il processo di rimozione della caffeina viene applicato ai chicchi di caffè ancora crudi. Del resto, la caffeina, alcaloide contenuto in tutti i tipi di caffè verde, sostanzialmente non conferisce aroma o gusto allo stesso neppure dopo la tostatura. Il caffè decaffeinato nasce perché i consumatori che desiderano godere dei gusto e dell'aroma inalterato della apprezzata bevanda, vogliono limitare l'introduzione della "parte" stimolante dei caffè.
Per decaffeinare il caffè esistono differenti modi basati sulla estrazione della caffeina tramite particolari sostanze, che hanno la caratteristica di dissolvere specifici componenti chimici solidi e rimuoverli durante i processi di estrazione.
Con l'anidride
carbonica: I chicchi verdi vengono inumiditi con vapore e acqua fino a
raggiungere la giusta percentuale di umidità (max 40%).
|